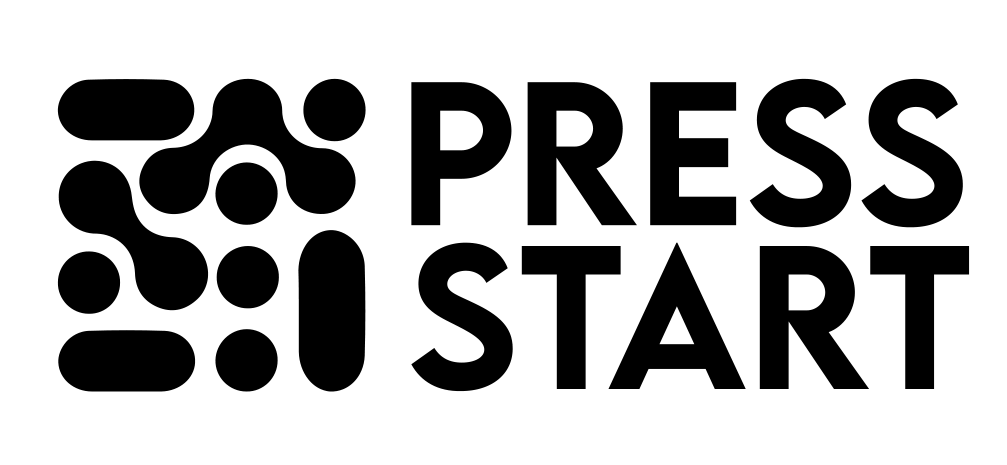Origine dell’ epigenetica
L’ EPIGENETICA Il termine “epigenetica”, dal greco “epi” (al di sopra)” e “gennitikòs” (collegato all’eredità familiare), e quindi “sopra la genetica”, è attribuito al biologo Conrad Hal Waddington (1905-1975) che, nel 1942, definì questa disciplina “la branca della biologia che studia le interazioni causali fra i geni ed i loro prodotti e costruisce il fenotipo”.
Mentre il genoma è l’insieme dei geni del DNA che non sono soggetti a cambiamenti nel corso della vita, l’epigenoma è l’insieme delle molecole che rendono possibili cambiamenti della espressione dei geni senza però modificare la sequenza dei nucleotidi che compongono il DNA, cioè l’ordine di successione delle basi azotate nei segmenti di acido nucleico.
Il genoma è stato paragonato ad una grande libreria in cui ogni “libro” rappresenta un gene. Su alcuni libri si trovano dei “post-it”, ovvero delle etichette che indicano quali libri (geni), devono essere letti e quali no. Il genoma può anche essere paragonato ad una grande orchestra che esegue un brano musicale utilizzando il solito spartito (DNA) ma le cui note sono interpretate in modo diverso o con strumenti diversi.
L’epigenetica, in conclusione, studia i meccanismi di funzionamento del genoma e come i geni sono espressi in modo coordinato. Modificazioni epigenetiche possono manifestarsi in risposta a segnali interni durante l’embriogenesi ed a segnali esterni che si manifestano nel corso della vita.
Segnali epigenetici sono rappresentati da: 1) metilazione del DNA, 2) metilazione ed acetilazione degli istoni e da 3) RNA non codificanti proteine che modificano l’espressione dei geni. Fino a pochi anni fa l’insieme di tutto il DNA nucleare non codificante proteine, che rappresenta oltre il 90% del genoma umano, è stato definito DNA spazzatura (junk DNA), ovvero materiale inerte, di significato oscuro. Oggi invece è stato dimostrato il suo ruolo come meccanismo di regolazione epigenetica. Modificazioni epigenetiche possono essere trasmesse da una cellula in fase di duplicazione alle cellule figlie ed anche dai genitori alla prole. Tali modificazioni possono contribuire all’esordio di numerose patologie compresi i tumori. I segnali epigenetici influenzano il fenotipo, sono ereditabili ed in parte reversibili. Meccanismi epigenetici si manifestano ogni giorno durante tutto l’arco della vita. Se consideriamo l’organismo come un sistema aperto è possibile comprendere come qualsiasi fattore esterno/interno può interferire con il DNA nucleare e modulare l’espressione genica con effetti sul fenotipo. Fra i numerosi meccanismi risultano fattori personali e ambientali: lo stile di vita, le abitudini personali (fumo, alcol, sostanze illecite), l’attività fisica, la sedentarietà, le condizioni di stress, l’invecchiamento (Aging), l’inquinamento, gli xenobiotici (sostanze estranee all’organismo) ed i farmaci. Il regime alimentare e la varietà dei cibi che vengono consumati ogni giorno sono da considerare sia modulatori metabolici sia agenti e modulatori epigenetici con effetti sull’espressione genica. È stato inoltre dimostrato che le scelte alimentari ma, più in generale, lo stile di vita dei genitori, possono avere ricadute sulla prole. I cambiamenti epigenetici che si verificano durante lo sviluppo embrionale hanno un maggior impatto sullo stato epigenetico dell’organismo in quanto interessano cellule staminali embrionali che sono caratterizzate da un notevole potenziale proliferativo e la capacità di differenziarsi in qualsiasi tipo di cellule. Se le modifiche del DNA persistono nel tempo possono portare a difetti di replicazione, all’arresto della trascrizione dell’RNA, o rappresentare modelli mutageni durante la sintesi degli acidi nucleici.
Featured image by: Christoph Bock, Max Planck Institute for Informatics – Opera propria