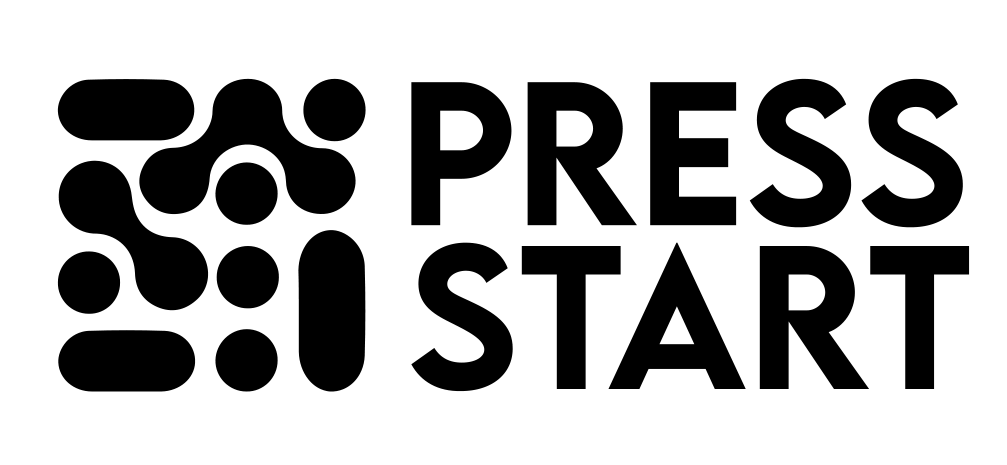La senescenza cellulare, descritta negli anni 60 del 1900 da Leonard Hayflick e Paul Moorhead, è caratterizzata dalla presenza nei tessuti dell’organismo di cellule che non sono più in grado di dividersi ed essere eliminate dal sistema immunitario. Le cellule senescenti resistono all’apoptosi e producono un «secretoma» bioattivo denominato SASP (Senescence Associated Secretory Phenotype) che è un fenotipo secretorio proinfiammatorio. Esse sono molto attive metabolicamente e producono specie reattive dell’ossigeno (ROS), interleuchine e citochine infiammatorie con attività autocrina e paracrina.
La senescenza cellulare riveste un ruolo complesso che dipende dall’età dell’organismo
▶ in un organismo giovane ha azione benefica essendo essenziale per lo sviluppo embrionale, (le cellule senescenti vengono eliminate dalle cellule immunitarie ai fini del modellamento del corpo), la rigenerazione dei tessuti e come barriera contro il cancro non essendo in grado di proliferare.
▶ in un organismo vecchio, al contrario, il numero di cellule senescenti aumenta e ciò è dovuto anche ad una minore attività del sistema immunitario. Come del SASP si realizza uno stato infiammatorio cronico di basso grado ed una secrezione elevata di fattori pro-infiammatori e pro-ossidanti da parte delle cellule senescenti che rappresentano la causa principale degli effetti dannosi. Le modificazioni biochimiche che si verificano durante l’invecchiamento e l’attivazione dell’inflammasoma NLRP3 contribuiscono all’infiammazione cronica (Inflammaging) (Gritsenko et al., 2020). Nei tumori SASP è causa dei cambiamenti del microambiente tumorale che favoriscono la progressione neoplastica.
Nei modelli animali l’eliminazione di cellule senescenti ha dimostrato effetti benefici in termini di longevità e salute. Numerose molecole hanno la capacità di stimolare vie di segnale specifiche all’interno delle cellule senescenti tanto da spingerle verso l’apoptosi (attività senolitica). Fra i fitochimici risultano la quercetina, la fisetina ed analoghi del curcumin (EF24). Tali composti sono definiti molecole senolitiche. Alcune sostanze (fisetina) hanno anche attività senomorfica: riducono cioè il rilascio di molecole infiammatorie da parte delle cellule senescenti.